
Il giornale la Repubblica del 3 febbraio in un articolo di Massimo Giannini dedicato alla generalizzata e composita rivolta dei contadini europei titolava «le proteste degli agricoltori: il doppio schiaffo dei nuovi kulaki». L’uso spregiudicato del termine “kulako” per definire l’agricoltore in sommossa di questi giorni è suggestivo. Sappiamo che il termineorigina dal “turco-tataro” e che divenne comune nel gergo popolare tra i russi delle campagne nel suo senso figurato di “arraffatore”. Questo sostantivo andò poi a definire
quello strato sociale delle campagne che risultò dalla riforma agraria del 1906 nella Russia zarista e che prevedeva l’assegnazione delle terre ai contadini attraverso il pagamento in denaro. Un passaggio che si rendeva necessario per velocizzare l’accumulazione nella estesa campagna russa, che per una serie di circostanze storichemateriali arrivò in ritardo a sviluppare quei rapporti di mezzadria nonostante la riforma della servitù del 1861, che viceversa si era sviluppata in maniera più marcata nelle regioni più occidentali dell’odierna Ucraina, nelle quali già sotto il possedimento della Confederazione Polacco-Lituana e fin dal 1500 gli investitori di capitali e ricchi mercanti tedeschi, olandesi e francesi favorivano la produzione delle derrate agricole per l’esportazione nell’Europa continentale e dunque alimentando aspettative di maggiori guadagni. Un fattore materiale che andò a comporre il quadro generale della relazione storica conflittuale tra città e campagna, che sarebbe divenutosuccessivamente nella Russia bolscevica l’elemento sociale endogeno cavallo di troia del processo storico impersonale della penetrazione finanziaria dei paesi imperialisti occidentali ed anche l’anello reale della aggressione militare contro la rivoluzione bolscevica, negli anni venti e in quelli a seguire. Il fiore all’occhiello della ideologia politica liberale che si ergeva adifesa dei diritti di libera imprenditorialità dei piccoli proprietari contadini contro il “modello” del comunismo e del bolscevismo che voleva limitarne i profitti.
Che Massimo Giannini usi il termine kulaki in tonodispregiativo, piuttosto che la denominazione di “piccoli imprenditori”, è appunto indicativo del punto di ebollizione senza soluzione del conflitto storico che il modo di produzione determina e acuisce nel rapporto città e campagna nel tempo generale della sua crisi.
In Italia nel 2020 venivano registrate 1,13 milioni di aziende agricole, il 30% in meno rispetto al censimento del 2010. La dimensione media per azienda del suolo agricolo è di circa 12 ettari di terreno, al di sotto delle medie europee che in ogni caso sono lontanissime dalle dimensioni delle farm agricole degli Stati Uniti. 700 mila aziende, quindi più del 60%, sono registrate in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. A fronte del calo delle unità aziendali, che è un tratto comune a tutta l’Europa e al Nord America, la dimensione media delle aziende è aumentata,indicando un processo continuo di concentrazione delle proprietà determinato dalla concorrenza e dal mercato. Mentrein certe aree rimane consistente la presenza di piccoli agricoltori, il processo di concentrazione e di aumento della dimensione media delle aziende agricole si dà soprattutto nell’Italia nord occidentale, in Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Emilia Romagna e Sardegna dove dal 1982 ad oggi sono scomparsi due terzi delle aziende agricole. Un processo di concentrazione accompagnato anche dalla riduzione del suolo agricolo utilizzato che è stato pari al 19% negli ultimi 40 anni come risultato dei processi industriali e di urbanizzazione.
Un combinato di fattori del processo della produzione del valore e del mercato che hanno determinato una divaricazionecrescente tra produzione agricola, distribuzione e industria agroalimentare all’interno delle nazioni più avanzate. L’industria agroalimentare italiana, che trasforma i prodotti agricoli,produce prevalentemente per l’export utilizzando come materia prima sempre meno i prodotti autoctoni, mentre la produzione agricola locale è costretta a coltivare una merce secondo le necessità e gli input della grande distribuzione multinazionale e dell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, mettendo l’agricoltore europeo di fronte a una doppia concorrenza difronte alle produzioni delle merci agricole estere: sul mercato dell’offerta rivolta alla industria agroalimentare e sul mercatoper il consumo diretto sia sui mercati locali che su quelli globali. Di fatto i cosiddetti “kulaki” europei non sanno più a chi vendere a causa di costi di produzione che rendono la loro mercesempre meno concorrenziale, che li costringe spesso a venderesotto costo per vincere la sfide della concorrenza sul mercato generale della domanda. Anche l’export dell’industria agroalimentare italiana sempre più produce una merce made in Italy trasformando le materie prime acquistate dai produttori esteri e del cosiddetto “sud globale”, riuscendo così a piazzare i suoi prodotti sui mercati di Cina e degli Stati Uniti. O pensiamo che Ferrero, o Barilla producano la loro merce trasformando i prodotti della terra coltivati dai “kulaki” italiani? Già negli anni ‘80 il Gruppo Ferruzzi faceva da intermediazione commerciale per l’import dall’URSS di frumento e grano pari a 20 milioni di tonnellate all’anno che poi rivendeva all’industria agroalimentare italiana e europea, mentre viaggiava nel mondo il motto “dove c’è Barilla, c’è casa”.
Ora sembrerebbe che i contadini siano in rivolta contro la concorrenza dei prodotti agricoli esteri, contro gli sconti sui dazi concessi per l’import del grano Ucraino e di tutto quanto finiscea minor prezzo sulle tavole da pranzo dei consumatori europei. In realtà il nodo decisivo è che finiscono nella catena dell’industria di trasformazione agroalimentare italiana e europea. Il consumatore diretto che ancora percepisce un medio salario può anche optare di comperare un pomodoro migliore anche a un modico prezzo maggiorato, perché corrisponde a una soddisfazione maggiore per la pancia. Ma di fatto o questo volume della domanda si restringe per le condizioni economiche della città e della dieta dimagrante imposta ai suoi consumatori e ai lavoratori, oppure la stessa capacità di produrre volumi di pomodoro di buona qualità capace di coprire la domanda come merce per il consumo diretto o come asset di capitale è impossibile per quelle che sono le leggi di un modo di produzione impersonale. Nessuno paese al mondo, incluso gli Stati Uniti hanno la capacità di coprire il fabbisogno generale di materie prime agricole per la domanda di consumo e della produzione.
Se il consumatore medio europeo ancora si trova nella condizione di poter scegliere il pomodoro, viceversa l’industria agroalimentare che deve nutrire il valore e non lo stomaco non può scegliere.
Questo è il primo chiarimento da tenere a mente. Tant’è che da decenni, per effetto di un mercato e della concorrenza mondiale che attira i capitali laddove c’è più possibilità di valorizzazione, i fatturati delle piccole e medie imprese agricole dell’occidente si compongono sempre più con i fondi e i finanziamenti statali. Negli Stati Uniti le farm agricole, che da decenni producono in maniera monoculturale per l’export di cereali e mais in Asia e di sementi per l’America Latina, devono il 60% del loro fatturato annuo agli aiuti dello Stato Federale. Nella UE i fondi di sostegno ai produttori agricoli ammontavano nel 2019 a più quasi 50 miliardi di euro. Nel 2022 sono saliti sopra i 70 miliardi. La produzione agricola della UE in cambio ha contribuito solo per l’1,3% del PIL dell’Unione Europea, benchégli occupati nel settore sono poco più di 9 milioni. “Ma di cosa stiamo parlando” verrebbe da dire a un economista borghese? Massimo Giannini non si pone esplicitamente la domanda, una domanda che impone alla politica di Bruxelles alle prese con una crisi generale dell’accumulazione di valore e il declino dell’Europa di iniziare a dettare delle condizioni agli agricoltori.
Nella fase tumultuosa della rivoluzione industriale e dei processi di urbanizzazione la produzione agricola doveva corrispondere a sfamare le bocche della forza lavoro e il consumo diretto della città per accrescere l’accumulazione, mentre la fabbrica della città produceva quei macchinari necessari a migliorarne la produttività e aumentare le rese agricole, stringendo così entrambi in una relazione combinata finalizzata alla accumulazione generale. Ai contadini, che aspiravano di arricchirsi velocemente, il processo impersonale della storia imponeva che essi investissero gran parte dei loro ricavi per migliorare la produttività e accrescere le rese agricole, la loro “parsimonia” negli investimenti o nei consumi veniva considerata avarizia dell’arraffatore a discapito di una comunità città del valore che comunque produceva anche per la campagna. Ai giorni nostri la maggior quota della produzione agricola non può che finire nei circuiti delle catene multinazionali della grande distribuzione e dell’industria di trasformazione che devono competere con altrettanti colossi. Il piccolo agricoltore europeo di oggi, paragonato impropriamente al “kulako” di ieri, non vive più all’interno della stessa relazionedi scambio combinato di una volta con il mercato della città, è determinato viceversa in una relazione di scambio diretta con ilcolosso multinazionale, che si comporta come il padrino mafioso della metropoli imperialista, imponendo il prezzo delle merci, cosa produrre e in quanto città dell’Occidente è divenuta una idrovora grassa di iperconsumo che offre in cambio sempre di meno al contadino che aspira al profitto ma non riesce a sostenere la concorrenza.
Insomma le leggi del modo di produzione, che il liberismo ha rincorso ed esaltato, presentano il conto di un tempo finito del suo tumultuoso sviluppo.
La produzione agricola europea è insufficiente a coprire il fabbisogno del consumo diretto delle città europee e dell’industria di trasformazione agroalimentare. Le pance grasse di città e industria sono abituate alle leccornie.
La legge impersonale dell’accumulazione, a questo stadio di sviluppo del modo di produzione capitalistico, impone che gli agricoltori producano essenzialmente per la trasformazione industriale e non per portare il prodotto sul mercato per il consumo diretto. In sostanza l’Europa e la città europea, sia per il consumo e sia per la creazione del valore aggiunto ulteriore attraverso la trasformazione del prodotto da parte dell’industria agroalimentare, ricorre ai prodotti e alle risorse della terra del “sud globale”, il cui prezzo è decisamente concorrenziale per le condizioni misere dei lavoratori della terra e delle sue masse lavoratrici in virtù di un secolare saccheggio predatorio delle sue materie prime. Il suolo agricolo di tutto il mondo diviene sempre meno fertile, rischia di inaridire, per le leggi che muovono un modo di produzione succhione in continua ricerca della super produttività intensiva del suolo e dei pascoli, in particolare delsuolo fertile dell’India, dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina imposta dalle multinazionali dell’agrobusiness. Viceversa in Europa il buon senso storico acquisito nei secoli di rispettare i tempi del maggese per far riposare i campi e rigenerare il suolo diviene una pratica incompatibile con la produzione del profitto generale e fa infuriare gli agricoltori.
Anche l’uso di forza lavoro immigrata ridotta a nuova schiavitù nelle campagne europee si traduce esclusivamente nel vantaggio della grande distribuzione multinazionale e della industria di trasformazione agroalimentare che produce per l’export. Al “pappone” contadino europeo rimane poco in tasca, perché il grosso del bottino va alle grandi multinazionali dell’agrobusiness, dell’industria di trasformazione e della distribuzione. Ma anche il padrino europeo della città tempio della merce viene a trovarsi in braghe di tela di fronte alla furia degli agricoltori, finalmente la pancia grassa della città europeainizia a fare i conti con una dura dieta dimagrante e con una contraddizione irrisolvibile dai risvolti implosivi.
Salutiamo, perciò, le mobilitazioni degli agricoltori in tutta Europa di questi giorni, come espressione di un ulteriore approfondirsi delle contraddizioni dell’insieme del modo di produzione, in modo sempre più caotico del rapporto degli uomini con i mezzi della produzione, che legano la campagna alla città per le finalità dell’accumulazione del valore e dello scambio e nessuna rivolta ai bisogni umani, al rispetto della natura e per la rigenerazione del suolo.
Diciamo, perciò, a chiare lettere, che non sosteniamo le loro rivendicazioni dettate dalla necessità di recuperare una produzione di valore e della merce della città.
Una questione di fondamentale importanza che riemerge esplosiva in Europa dopo aver bussato nel 2020 all’India del governo Modi.
Viva la “fame” in Europa.
ALGAMICA
Per approfondimenti sulla questione contadina rimandiamo all’articolo del 18 dicembre 2020 di Michele Castaldo che potete trovare qui
o qui




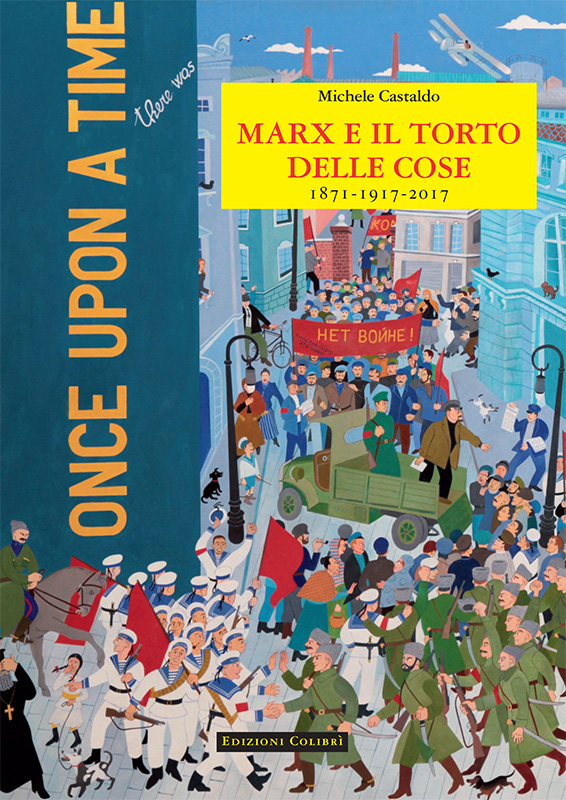
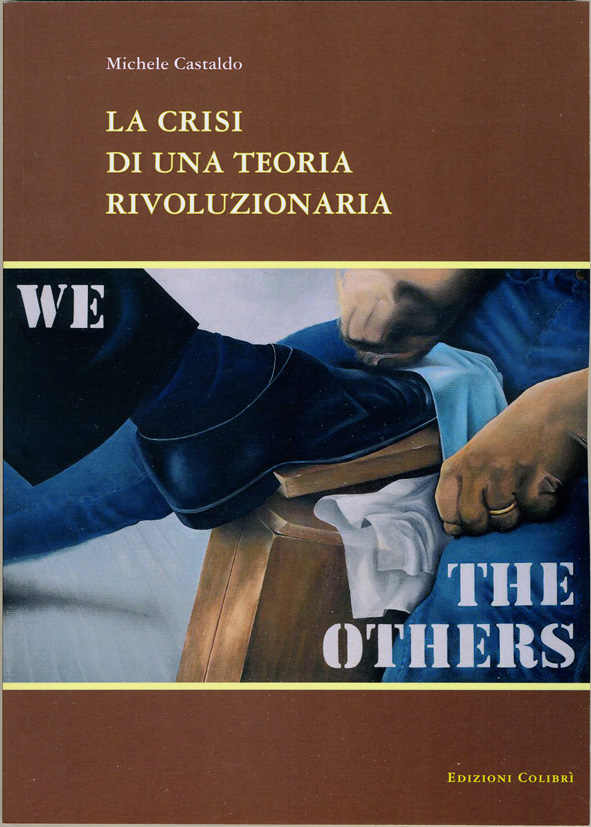
Comments powered by CComment